Prima o poi vorrei scrivere qualcosa sui nomi.
Molte sono le citazioni latine che attribuiscono al nome la funzione di sostanziale rappresentazione naturale del nominato, o addirittura di presagio di tale natura. Ma alcune volte è proprio il suono dei nomi delle cose, o delle persone, a giocare una parte rilevante nella percezione della realtà. Tanto da farci chiedere cosa fosse causa e cosa fosse effetto tra il nome e la cosa, o la persona.
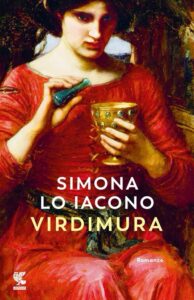
Nell’ultimo romanzo di Simona Lo Iacono, Virdimura, Guanda edizioni, ci sono alcuni nomi di persone e di cose che sono davvero formidabili.
A partire proprio dal nome della protagonista e titolo del romanzo stesso. Virdimura, un nome che risuona di speranza e di solidità, di vita e di casa, di piante e di ricovero, di cura, con cui fa pure rima.
Tra tutti, in particolare, e per motivi squisitamente personali, il nome che più mi ha risuonato è quello del padre di Virdimura: Urìa.
Nella mia infanzia risuona un nome simile: Uriele. Un nome inconsueto, che non ho mai più incontrato in alcuno. Era il padrone di casa della nostra prima casa, quella dove ho vissuto dalla nascita fino ai nove anni.

L’appartamento in cui vivevamo era quasi indistinto dal resto della casa. Dal pianerottolo si accedeva a un piccolo androne che dava su tre porte, di cui una era quella della nostra casa.
Si era realizzata una tale confidenza tra le famiglie che spesso le porte all’interno dell’androne restavano aperte e sembrava di vivere in un’unica casa.
Uriele era un uomo buono, l’uomo buono per antonomasia, sempre gentile, educato e generoso. Avevano origini nobiliari, soprattutto la moglie, Anna, ma possedevano entrambi una particolare nobiltà d’animo, che non consentiva loro atti di superbia o di tracotanza alcuna. Di Uriele si poteva dire che “Aveva il fascino di un sovrano e l’umiltà di un mendicante.”
Aveva un cugino con lo stesso cognome, ma di cui non ricordo il nome, che era medico. Un medico felicemente riconosciuto come dotato di grande sapienza e di altrettanto grande umanità. Di cui ricordo ancora la voce carezzevole e la somma gentilezza con cui individuò un mio problema aiutandomi a superarlo.
Sia Uriele che il cugino morirono troppo presto, lasciando di loro un ricordo così enorme da colmare il grande vuoto che ne venne.
Sarà per questo effetto alone di Uriele – Urìa, che io, leggendo questo delizioso racconto di Simona Lo Iacono, mi sono ritrovato a passeggiare molte volte dentro me stesso, dentro la mia memoria diretta, dentro la mia memoria ancestrale, inconsapevole, che veniva risvegliata dalle parole e dalle pagine.
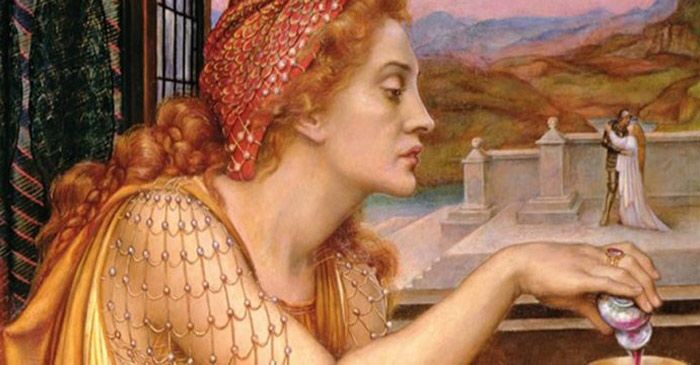
Simona Lo Iacono racconta ancora una volta di una donna, di una donna esistita sei/settecento anni fa. Nel Pantheon che ci sta regalando libro dopo libro, è il momento di una donna medico, una dutturissa. La straordinaria storia di una scienziata del Milletrecento, di Catania, della sua vita alterna tra fortune e disgrazie, durante la quale ha esercitato la più umana e la più divina delle facoltà: si è presa cura di altri uomini, di bambini, di altre donne, senza guardare alla loro provenienza, al loro stato, alla loro dimensione religiosa.
Le vicende davvero incredibili della sua vita la portano a creare un ospedale vero e proprio, in cui esercitare la cura, e insegnare la cura. Sempre all’insegna dell’amore con cui la cura moltiplica i suoi effetti.
“Tutte chiedevano aiuto, e – in tutte – questo lamento era il dolore stesso della terra, ed essa, la terra, era un unico corpo piagato, il cui medico non poteva nulla, se non avvertirne la debolezza, per sanarla – più che con medicamenti – con la compassione”
“Così, dopo averle guarite, le istruii. A tutte insegnai l’arte della medicazione, e a tutte spiegai come fasciare, spurgare, disinfettare”
Virdimura apprende la sua umana scienza e la sua divina capacità dagli insegnamenti del padre, di Urìa. Uno straordinario esempio di umanità e cura.
“Ricordati figlia, mi spiegava, ti diranno che esiste distinzione tra la casta dei medici d’urina, quelli di polso e quelli di coltello, gli unici a cui spetta operare. Ma tu sappi che non puoi praticare arte chirurgica senza conoscenza dell’unità. E ancora. Ti costringeranno a portare sulle vesti la rindella, perché si veda che sei figlia di giudeo. Ma tu indossa un solo simbolo: pietà umana, dolore per l’altro. E se ti diranno che a te compete unicamente far nascere figli, o accudire le madri, rispondi che l’arte medica attinge al mistero di Dio, che entrambi partorì i sessi, e fai commosso dovere verso chiunque ti chieda ristoro, sia esso masculo o fimmina. E se anche ti porteranno a giudizio, offri rispetto ai giudici ma non patteggiare. Ad ogni interrogazione rispondi sempre in una guisa: Non sentite lo grido delli ultimi che sale dalla terra?”

Non importa la latitudine in cui si operi, non importa il tempo in cui si viva, quando l’umanità diventa scandalosamente immagine del divino, la meschinità e l’invidia di chi non sa temperare il suo animo allo stesso modo, prorompe e spezza, aggredisce, tradisce e distrugge.
Così più volte il Potere nelle sue molteplici sembianze distrugge materialmente la casa della cura, e simbolicamente sporca di fango la fatica della cura di corpi e di anime.
Nonostante Urìa in nessun caso ceda al rancore e alla vendetta e ricominci ogni volta senza stanchezza, una volta di queste Urìa sarà costretto a sparire, anzitempo, troppo presto, come Uriele e il cugino medico, lasciando a Virdimura l’onore e l’onere di continuare a regalare gocce di splendore al dolore umano. Superando l’impotenza del limite umano con la taumaturgica divinità del sorriso.
“Durante il ricovero venivano curate con musica e bagni, fomentazione, massaggi, compresse e fasciature. Altri trattamenti molto usati erano la flebotomia, il salasso, il cauterio. I rimedi farmaceutici includevano sedativi, stimolanti, purganti, emetici e digestivi. Ma più di ogni altra cosa funzionava il sorriso, ampi sorrisi dispensati come cibo, due volte al giorno per disposizione del califfo, quattro se la luna era piena. Cinque in tempo di siccità.”
Ma non erano tempi comodi per chi si ostinava a praticare umanità e divinità in questo modo, non lo erano, soprattutto, per una donna. Virdimura, che si ostinava a donare se stessa, la sua esperienza, gli insegnamenti preziosi di Urìa agli altri non era definibile, non era riconoscibile per il Potere.
“Ero diavola, dicevano i cristiani. Ero impura, dicevano gli ebrei. Ero perduta, dicevano gli arabi.”
Quando il Potere venne a cercarne ragione, i sacerdoti stessi non sapevano come definirla.
“Cerchiamo tale Virdimura, non vedova, non ammogliata, non figlia, non sacerdotessa, non santa”

Virdimura è un racconto speciale. Il racconto di una diagnosi che guarda alla dimensione unitaria del paziente, corpo e spirito, che non si concentra sulla malattia, di una terapia basata sulla comprensione, sulla vicinanza, sull’amore, sul sorriso.
Il racconto della dimensione più alta della cura medica. Urìa, Virdimura, ma anche Josef e Pasquale, gli altri personaggi che riempiono di attenzione e cura questo romanzo, sono personaggi reali. Non solo perché Simona Lo Iacono ne ha studiato le origini, ne ha scovato i documenti, ne ha indagato fatti e verità, da sereno e giusto giudice com’è quando non scrive romanzi. Ma perché Simona Lo Iacono ha incontrato nella sua vita medici così. Tutti li abbiamo incontrati. Tanti ve ne sono da riempire schiere di angeli.
Anch’io ho il mio pantheon personale di medici che non hanno curato le mie malattie o dei miei cari, ma si sono presi cura di me e dei miei cari, guarendoci, quando possibile, dalle nostre malattie.
Se dovessi stilare qui un elenco sarebbe lunghissimo e ne dimenticherei sempre qualcuno. Mi limito a ricordarne simbolicamente per tutti solo due, oltre al cugino di Uriele già citato per altro fine.
L’indimenticabile dott. Piccione, e l’infaticabile dott. Moruzzi. Chi li conosce non ha bisogno che io spieghi perché. Chi non li conosce li sostituisca pure con i propri angeli di cura e capirà perché mi sono spinto a citarli, andando oltre la discrezione di questo blog.
Dicevamo che Virdimura è un racconto speciale.
Un racconto dove anche la morte è un evento condiviso, attraversato con il sorriso, con il canto, con tutto l’amore che si può donare a chi compie il viaggio, e che può ricevere chi di qua resta.
Dove chi parte porta con sé il sorriso di chi ti lascia partire, di chi ti lascia rientrare nel flusso da dove vieni, dove ritrovi chi ti ha preceduto.
Dove chi resta trattiene con sé la serenità di chi si abbandona, l’amore che non si spegne (a – mors), nella certezza di ricongiungersi nel flusso in cui la luce illumina tutte le cose.
Dove si insegna a dutturi e dutturisse che la nascita e la morte richiedono la stessa cura.
“A queste insegnavo che i riti dell’inizio erano come quelli della fine, esigevano dimestichezza e rassegnazione.”
Dove si riconosce al medico una dimestichezza con l’eterno e con il tutto, e proprio in funzione di questi pietosi commerci con la morte.
“il medico è colui che maggiormente interroga l’eternità, colui che ha più affinità con il transito dei morti.”
Virdimura è un racconto che cura esso stesso. E questo è il contributo di Simona Lo Iacono a questa storia. Ci ha già mostrato più volte che la sua penna è capace di modularsi sul timbro di chi racconta, lo abbiamo plasticamente notato nel Mistero di Anna, dove la bambina Anna e Anna Ortese avevano una loro specifica scrittura, musica, sinfonia di tono e parole.

In questo speciale romanzo Simona Lo Iacono ci dona una lingua curatissima nei toni, nelle parole, nelle forme, che ci suona come una carezza, come un canto, come se dalle pagine la scrittura di Lo Iacono ci sorridesse a ogni parola.
Terapeutico, curativo, questo racconto ci accompagna e ci porta oltre le sponde del tempo, dove l’umano e il divino si incontrano. Ci adagia sulla sabbia e ci culla con il suono e il soffio delle onde del mare. Ci accarezza e ci insegna che anche i dolori possono diventare gioie, che anche nel male stesso possiamo trovare la forza per superarlo.
Quando sulla soglia della fine della sua vita ricorderà tutto questo, Virdimura racconterà:
“Quello che potevamo fare noi, figli rotti, sguarniti, mezzi azzoppati dalle intemperie, era accogliere il viaggio. Inserirci nel flusso, non per guidarlo, ma per curarlo. Per amarlo”
Con questo romanzo Simona Lo Iacono mette a frutto tutta l’arte narrativa accumulata nel tempo, si inserisce anche lei nel flusso, e ci dona un grande, osceno e scandaloso, atto d’amore.

